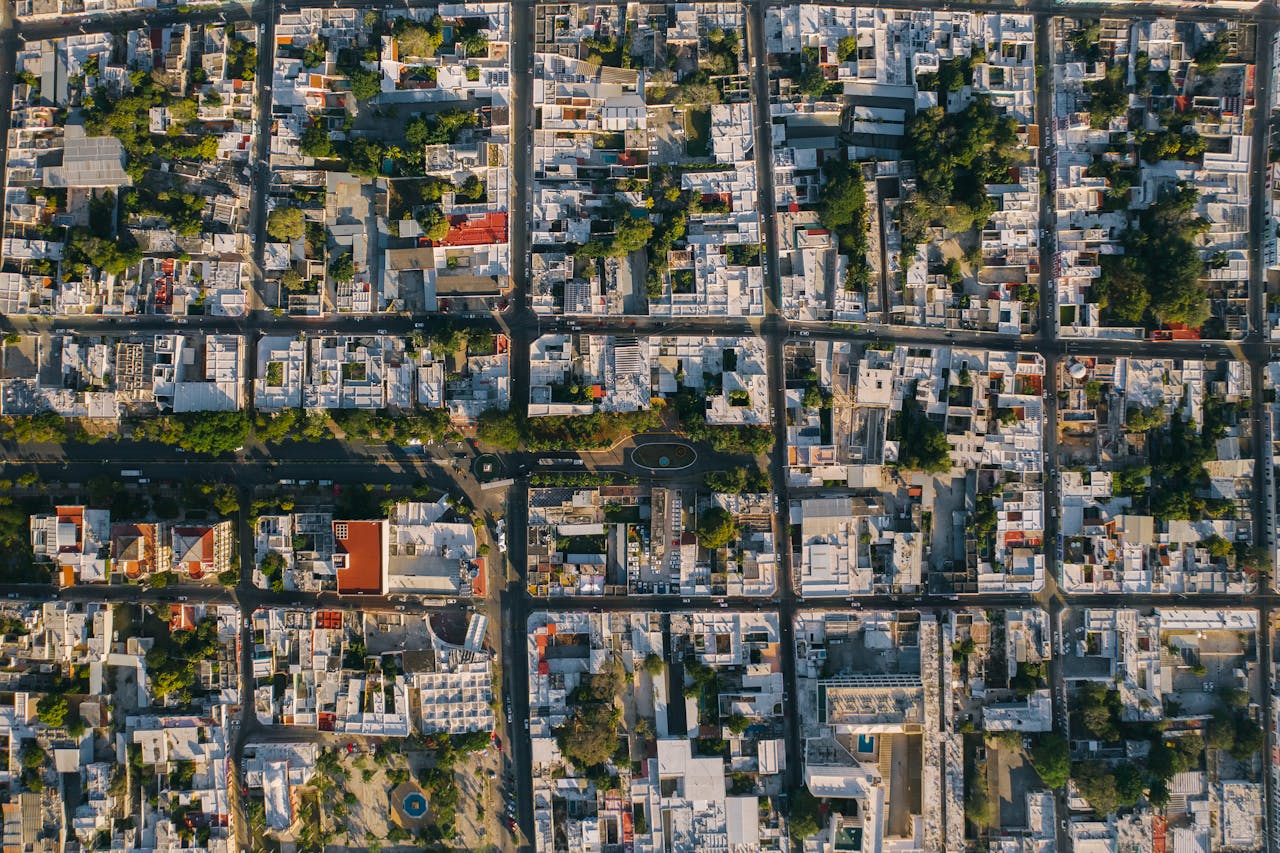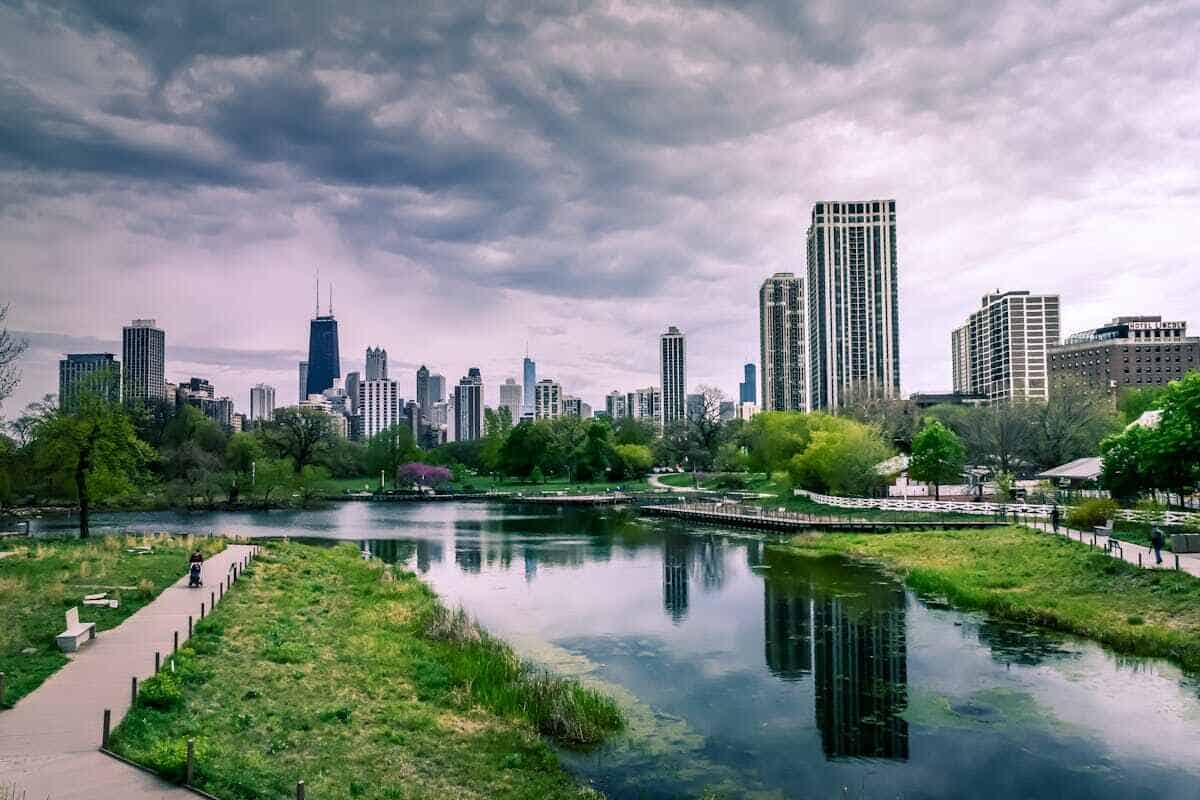Dopo numerosi interventi legislativi dell’UE anche il nostro paese si è mosso per riscrivere le regole di gestione dei rifiuti tessili, che dal 2022 sarebbe d’obbligo raccogliere in maniera differenziata. Le nuove regole vedranno i produttori svolgere un ruolo da protagonisti nella gestione
Il 2 aprile scorso il Ministero dell’Ambiente e per la sicurezza energetica (MASE) ha messo in consultazione il nuovo modello di gestione dei rifiuti tessili incardinato su uno schema di responsabilità estesa del produttore, ossia affidare a questi ultimi il compito di raccogliere l’equivalente in peso dell’immesso nel mercato per ogni singolo anno. A dare la stura a questa iniziativa legislativa le numerose mosse della Commissione Ue, da tempo sulle tracce di un nuovo modello di gestione dei rifiuti tessili, finalmente sostenibile, all’interno dello spazio europeo.
Il testo si propone di promuove “la sostenibilità della filiera dei prodotti tessili, la progettazione degli stessi e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la generazione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo, finalizzata ad assicurare che la raccolta, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei prodotti diventati rifiuti avvengano secondo le finalità prevista dal TUA”.
L’intera impalcatura pone l’accento, dunque, sull’obbligo di gestire i rifiuti tessili in ossequio alla gerarchia dei rifiuti, promuovendo azioni “per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di tutti i prodotti tessili adatti ad essere preparati per il riutilizzo, riparati e riciclati, al fine di favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti”.
Un cambio di impostazione copernicano, considerato che finora non è mai stata improntata nessuna governance a livello nazionale, lasciando che solo gli operatori del riutilizzo si muovessero per la raccolta, tanto che solo una frazione residuale di rifiuti tessili è stata finora raccolta in maniera separata, poco meno del 19% (Ispra, 2025). Anche l’entrata in vigore nel nostro paese nel 2022 dell’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili ha cambiato di poco o nulla la realtà.
Un lungo percorso normativo
Un percorso, quello del legislatore nazionale, iniziato con la Direttiva 851/2018, ha dato tempo fino al 1 gennaio 2025 perché scattasse per tutti gli stati membri l’obbligo della raccolta differenziata, poi rafforzato con la Strategia Ue sul tessile, nell’ambito del Green Deal europeo, e ancora con il Nuovo piano d’azione per l’economia circolare, per finire con la riforma della Direttiva Quadro sui rifiuti ha previsto nuove regole per i rifiuti alimentari e soprattutto per quelli tessili.
Se rispetto ai primi l’obiettivo principale è ridurre lo spreco alimentare entro il 2030, per i tessili si prevedono una serie di misure, tra cui l’introduzione, appunto, di un meccanismo di responsabilità estesa del produttore, nel tentativo di rivoluzionare completamente il paradigma di gestione, assicurando un maggiore spazio alla prevenzione e alla costruzione di una catena del valore capace non solo di rafforzare le pratiche di riutilizzo ma, soprattutto, di riciclo, cioè di recupero di materia, pratica che ancora oggi rimane solo sullo sfondo, in Italia come nel resto dell’Europa. Intanto dal primo gennaio di quest’anno tutti i paesi hanno l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili, obbligo che come già detto l’Italia ha anticipato di tre anni.
Le ragioni della svolta
L’esigenza di intervenire in maniera netta nella gestione dei rifiuti tessili deriva da tre fattori: il primo riguarda l’impatto ambientale del settore, il secondo, la continua crescita dei rifiuti tessili prodotti, la terza, l’inesistenza in tutta l’UE di efficienti modelli di raccolta e di valorizzazione.
Rispetto al primo fattore, è opinione condivisa dalla scienza che la produzione tessile sia responsabile di circa il 20% dell’inquinamento globale dell’acqua potabile a causa dei vari processi a cui i prodotti vanno incontro, come la tintura e la finitura, e che il lavaggio di capi sintetici rilasci ogni anno 0,5 milioni di tonnellate di microfibre nei mari. Inoltre, la produzione tessile necessita di molte risorse, tra cui molta acqua, senza contare l’impiego dei terreni adibiti alla coltivazione del cotone e di altre fibre. Alcune stime indicano che per fabbricare una sola maglietta di cotone occorrano 2.700 litri di acqua dolce, un volume pari a quanto una persona dovrebbe bere in 2 anni e mezzo.
Nel 2020, il settore tessile è stato la terza fonte di degrado delle risorse idriche e dell’uso del suolo. In quell’anno, sono stati necessari in media nove metri cubi di acqua, 400 metri quadrati di terreno e 391 chilogrammi di materie prime per fornire abiti e scarpe per ogni cittadino dell’UE. Peraltro la gran parte delle risorse provengono da extra UE. Secondo le stime dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), per produrre la quantità di abbigliamento, prodotti tessili e calzature utilizzati nell’UE nel 2020, l’80% delle materie prime primarie, l’88% dell’acqua, il 92% dei terreni utilizzati e il 73% delle emissioni di gas a effetto serra erano associate a zone al di fuori dell’UE.
Rispetto alla crescita della produzione di rifiuti tessili, sebbene i dati siano ancora abbastanza carenti, secondo gli operatori del settore l’invasione nel mercato del fast e ultra fast fashion, ossia di abbigliamento discara qualità e a poco prezzo (quindi destinato a vita breve) ha fatto schizzare i quantitativi prodotti, anche se non sempre i dati sono in grado di registrate questo incremento. Gli ultimi dati aggiornati di Eurostat dicono che nel 2020 l’UE-27 ha prodotto quasi 7 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, più o meno 12 kg pro capite, di questi circa 6 kg di abbigliamento, 6,1 kg di tessili per la casa e 2,7 kg di calzature (EEA 2022).
Passando al terzo fattore, quindi, ancora oggi circa l’80% non è soggetto ad alcuna forma di raccolta differenziata e finisce nei rifiuti domestici indifferenziati, destinati a essere inceneriti o collocati in discarica, percentuale che in Italia arriva all’81% (Ispra, 2025). Gran parte dei rifiuti tessili raccolti è destinata al riutilizzo (tra il 50 e il 75%) all’interno dell’UE o esportata verso i mercati esteri.
La generalizzata disattenzione in termini di policy alla gestione del fine vita dei prodotti tessili ha comportato la mancanza di capacità di selezione e riciclaggio all’interno dell’UE, evidenziando la necessità di potenziare al più presto le infrastrutture materiali e immateriali per garantire una gestione più consono agli obiettivi della transizione ecologica
La riforma della Direttiva Quadro per un tessile più sostenibile
Come si diceva prima, l’urgenza di intervenire a sostegno di una transizione green più netta prevalentemente nei settori alimentare e tessile ha spinto l’UE a una modifica della cosiddetta Direttiva Quadro sui rifiuti (2008/98/CE). A metà febbraio di quest’anno la presidenza del Consiglio dell’Unione europea e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo preliminare sul nuovo testo.
L’accordo raggiunto si concentra proprio sul settore tessile (abbigliamento e accessori, calzature, coperte, biancheria da letto e da cucina, tende e cappelli), nel quale si prevede l’introduzione si regimi armonizzati di responsabilità estesa del produttore (EPR) che imporrebbero ai produttori di pagare un contributo necessario a finanziare i costi di raccolta e trattamento – che, come accade in tutti i modelli di questo tipo, verrà alla fine scaricato sul prezzo finale, quindi sul consumatore –, il cui importo dovrà essere calcolato anche in base al grado di circolarità e sostenibilità dei loro prodotti stessi.
Uno degli obiettivi più ambiziosi rimane quello di contrastare la sovrapproduzione di rifiuti tessili e le pratiche di fast e ultra-fast fashion, prevenendo la distruzione dei prodotti tessili invenduti. Secondo uno studio realizzato dall’Agenzia europea dell’ambiente, infatti, ogni anno in Europa vengono distrutte prima dell’uso dalle 264.000 alle 596.000 tonnellate di prodotti tessili (Staffetta Rifiuti 29/03/24), generando l’emissione di 5,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. In quest’ottica, gli Stati membri dovrebbero calcolare l’importo degli ecocontributi anche in base alla durata d’uso e alla durabilità dei prodotti che immettono sul mercato, incentivando anche per questa via il riutilizzo, quindi il second hand.