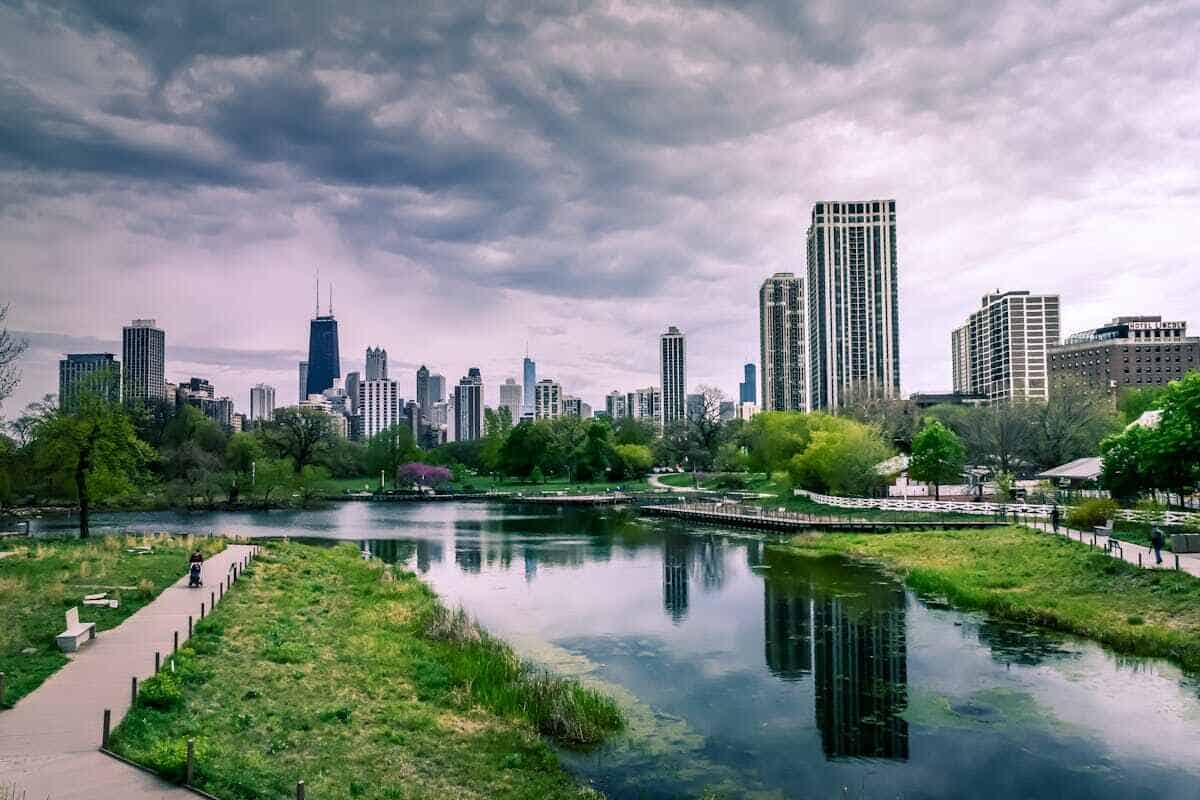Un quaderno di Ispra analizza i Piani comunali del verde di dieci città. Ancora poco diffusi, questi strumenti di pianificazione ecologica degli spazi urbani possano diffondersi sempre di più tra le amministrazioni locali del nostro Paese, indirizzando le trasformazioni urbane verso una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Torino, Vercelli, Bolzano, Padova, Rovigo, Parma, Bologna, Forlì, Livorno, Avellino: sono le dieci città al centro della pubblicazione di Ispra sui Piani comunicali del verde. L’obiettivo del quaderno, intitolato I piani comunali del verde: strumenti per riportare la natura nella nostra vita? è di incentivare l’uso dei piani del verde per garantire ai centri urbani uno sviluppo sano, inclusivo e resiliente. Questi sono, infatti, strumenti fondamentali per programmare lo sviluppo del verde urbano in un’ottica di riqualificazione territoriale e sostenibilità a lungo termine. E l’auspicio dei curatori del documento – che s’interroga sin dal titolo sulle potenzialità di questi strumenti di pianificazione locale per migliorare la qualità della vita – è che questi strumenti ancora poco diffusi di pianificazione ecologica degli spazi urbani possano diffondersi sempre di più tra le amministrazioni locali del nostro Paese.
“Parlare di Piani del verde diventa oggi questione centrale nelle politiche ambientali, sociali e di sostenibilità urbana a 360 gradi”, scrive nell’introduzione del quaderno Valeria Frittelloni, direttore Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale di Ispra. La pianificazione strategica del verde riveste un ruolo centrale per integrare le singole iniziative in una visione di medio-lungo termine, finalizzata alla costruzione di un sistema organico di infrastrutture verdi e blu nelle città.
Il contesto: la Strategia europea per la biodiversità
Le sfide che le città devono affrontare – e rispetto alle quali sta diventando cruciale integrare la natura nel paesaggio urbano – si chiamano cambiamento climatico, aumento demografico e perdita di biodiversità. La Strategia europea per la biodiversità al 2030 invita le città con più 20.000 abitanti a dotarsi di un Piano del verde urbano, ora chiamato Piano urbano per la natura. In linea con il recente Regolamento sul ripristino della natura (NRR) che pone target vincolanti di ripristino del 20% degli ecosistemi degradati europei entro il 2030, e del 100% entro il 2050.
I piani comunale del verde: uno specifico strumento tecnico
I Piani del verde sono descritti nelle Linee guida per la gestione del verde urbano del Ministero dell’Ambiente e richiamati dalla Strategia Nazionale del Verde Urbano. Si configurano come strumenti volontari e integrativi della Pianificazione Urbanistica Generale. Essi sono anche promossi dalla Legge 10/2013, che invita i Comuni a prevedere grandi aree verdi pubbliche, specialmente nelle zone a maggior densità abitativa, sottolineandone la funzione strategica nel contesto della pianificazione strutturale comunale.
“Per essere efficace e duratura l’infrastruttura verde e blu delle città richiede una pianificazione lungimirante, competente ed evidence-based, oltre che una realizzazione attenta e una gestione competente e responsabile, capace sia di tutelare e valorizzare il patrimonio verde esistente (quello più prezioso) sia di programmarne l’incremento con le piante giuste, al posto giusto e con le cure giuste”, scrive ancora Frittelloni, sottolineando l’importanza del coinvolgimento diretto dei Comuni nella realizzazione dello studio, in quanto sono in prima linea nel processo di transizione ecologica.
Perché un focus specifico sui Piani comunali del verde
In un capitolo della ricerca intitolato “Limiti e prospettive” viene spiegata la selezione delle dieci città prese in esame: la scelta cioè di concentrarsi esclusivamente sulle città che hanno redatto e chiuso il proprio Piano del verde. Dal volume sono quindi esclusi i Comuni che hanno avviato il percorso di redazione del Piano del verde (come per esempio Bergamo, Brescia, Firenze, Pesaro, Rimini, Trento) o stanno per implementarne pubblicamente i contenuti (Mantova) e quelli che, pur in assenza di uno specifico Piano del verde, hanno in qualche modo considerato il tema del verde urbano all’interno di altri strumenti di governo e pianificazione del proprio territorio (come Regolamenti del verde pubblico e privato o Piani di gestione del rischio delle alberate).
“La scelta adottata per il presente documento di concentrarsi esclusivamente sui Piani comunali del verde – si legge nel volume – rappresenta un primo approccio per capire il ruolo svolto dal capitale naturale nell’ambito degli strumenti di pianificazione locale, e il suo potenziale contributo nell’indirizzare le trasformazioni urbane verso una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica. I Piani del verde, in questo senso, rappresentano espressioni di una precisa volontà politica e di una maturità tecnica tali da assegnare alle aree verdi e blu urbane e periurbane il rango di oggetto specifico di pianificazione e tutela”.
Questo lavoro sui Piani comunali del verde “intende collocarsi come momento iniziale di un’attività orientata a monitorare nel tempo l’evoluzione di tale importante strumento di pianificazione nelle piccole e grandi città italiane”.
Due esempi: strategie e azioni dei Piani di Bolzano e di Avellino
A titolo illustrativo, riportiamo strategie e azioni messe in campo con i Piani del Verde di Bolzano e di Avellino.
Strategia e azioni del Piano del Verde di Bolzano
Le sfide principali cui il Piano del verde di Bolzano piano intende dare risposta sono la riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici (soprattutto ondate di calore e bombe d’acqua) e l’incremento del verde pubblico accessibile per i cittadini, attualmente inferiore allo standard minimo di 11,5 metri quadri per abitante previsto dalla legge provinciale “Territorio e Paesaggio”. Gli obiettivi che si pone il piano sono:
- Incrementare le dotazioni di spazi verdi pubblici fruibili, stimando un incremento per abitante fino a 17,61 m2/ab
- Avvicinare il verde ai cittadini, riducendo le distanze tra centri abitati e spazi verdi pubblici
- Aumentare gli spazi attrezzati per la comunità
- Aumentare la biodiversità in ambito urbano
- Valorizzare le infrastrutture blu grazie alla riqualificazione e alla rinaturalizzazione di tratti degradati ed ecologicamente impoveriti di fossi, canali e fiumi presenti all’interno del tessuto urbano
- Realizzare una densa maglia verde che, partendo dai fiumi innerva la città, mettendo a sistema l’esistente con il potenziale
- Attivare un “Green Ring” intorno al centro urbano incrementando l’accessibilità alle colline e alle aree ad alta quota, qualificando le passeggiate esistenti e migliorando l’interconnessione tra esse
Il Piano individua poi diverse soluzioni progettuali per ridurre la vulnerabilità di Bolzano agli impatti dei cambiamenti climatici (ondate di calore, alluvioni siccità), in cui la componente arborea, le soluzioni nature-based (rain garden, bacini di infiltrazione, strisce di impollinazione e prati fioriti) e la permeabilità dei suoli giocano un ruolo centrale, così come la realizzazione di bacini allagabili per il deflusso dei canali sotterranei e la gestione degli eventi di piena nelle aree verdi esistenti e in progetto, evitando le aree verdi in prossimità di zone abitate. Il Piano propone anche interventi di adattamento per il verde privato che corrisponde a circa l’80% del verde del Comune, tramite introduzione puntuale o diffusa di soluzioni nature-based nelle aree sportive superfici erbose in alternativa a soluzioni impermeabili (cemento, asfalto, ecc.), e l’inverdimento degli edifici con tetti verdi.
Numerose azioni sono inoltre finalizzate alla promozione della mobilità integrata con elementi di greening urbano, da realizzarsi in accordo con le previsioni del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), del Piano Urbanistico Comunale e del Piano Paesaggistico Comunale. In relazione alla mobilità attiva, il PdV si pone, fra gli obiettivi, anche l’attivazione di una Ringpromenade intorno al centro urbano al fine di incrementare l’accessibilità alle colline e alle aree ad alta quota, qualificando le passeggiate esistenti e migliorando l’interconnessione tra esse.
Particolare attenzione si pone alla biodiversità vegetale (attraverso, per esempio, la tutela della naturalità diffusa e l’incremento delle aree adibite ad orti urbani) e animale. In particolare, per quest’ultima si prevedono misure quali:
- Tutela dei viali alberati (per la nidificazione degli uccelli) e degli alberi maturi
- Creazione di strisce di impollinazione e di prati fioriti, fasce tampone lungo autostrade e ferrovie
- Creazione di habitat e stagni per fauna terrestre e acquatica nell’ambito dell’attuazione di nuove aree verdi pubbliche, già in previsione da PUC, nelle aree ripariali dei fiumi Isarco, Talvera e Adige
- Realizzazione di altane di osservazione degli animali per incentivare lo sviluppo di un turismo sostenibile e sensibilizzare la cittadinanza sugli aspetti ecologico-ambientali
Gli indicatori di monitoraggio dei Piani comunali del verde di Bolzano
Di particolare interesse anche gli strumenti di monitoraggio, qualitativi e quantitativi, riportati nel Piano. Infatti, per monitorare l’efficacia delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi viene proposto un set di indicatori, gran parte dei quali già in uso in città virtuose come Oslo, Graz, Vienna e Zurigo per monitorare costantemente la situazione degli spazi verdi urbani. Gli indicatori quantitativi selezionati sono:
- Quantità di aree boscate nell’area comunale (km2)
- Quantità di aree agro-produttive nell’area comunale (km2)
- Superficie occupata da spazi verdi pubblici in ambito urbano (m2)
- Superficie occupata da spazi verdi privati in ambito urbano (m2)
- Dotazione di spazi verdi pubblici (m2 /ab)
- Dotazione di spazi verdi pubblici collegati ad abitazioni (m2 /ab)
- Dotazione di spazi verdi pubblici collegati ad aree residenziali (m2 /ab)
- Dotazione di spazi verdi pubblici collegati a quartieri (m2 /ab)
- Alberi piantati all’interno delle sole aree pubbliche (n.)
Strategia e azioni del Piano del verde di Avellino
Il Piano del verde di Avellino va considerato alla luce della legge regionale Campania 2022, n. 13 “Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” che, tra le altre cose, mira al “rafforzamento delle reti infrastrutturali del verde e degli spazi urbani aperti” per perseguire gli obiettivi più generali di riduzione del consumo di suolo. La realizzazione dell’“Infrastruttura verde urbana” persegue le strategie seguenti:
- Difesa ambientale
- Risanamento idrogeologico
- Valorizzazione del sistema Natura con finalità varie (contenimento delle emissioni di CO 2 tramite forestazione urbana, disinquinamento dei suoli e delle acque, recupero della rete idrografica, consumo di suolo, valorizzazione del verde agricolo)
In linea generale, gli obiettivi del Piano di Avellino mirano:
- Alla ricomposizione nei tessuti urbani di tutte tipologie di aree verdi funzionali e di completamento delle parti costruite della città
- Al potenziamento del patrimonio arboreo, arbustivo ed erbaceo della città per mitigare l’isola di calore urbana e migliorare la percezione estetica del paesaggio
- La realizzazione di infrastrutture verdi come corridoi ecologico-paesistici per la definizione del Parco Intercomunale di Interesse regionale del Fenestrelle, che rappresenterebbe una best practice di cooperazione istituzionale (assieme ad Avellino sono interessati altri tre Comuni), e consentirebbe di migliorare l’accessibilità dell’area con percorsi ciclo-pedonali e incentivare notevolmente la mobilità slow
- Piantagione preventiva (o preverdissement) per le aree da bonificare dello stabilimento dell’ex Isochimica
Nel medio-lungo periodo invece dovranno essere necessariamente oggetto di valutazione le aree potenzialmente trasformabili e destinabili ad aree a verde o per la forestazione urbana. La vera scommessa della programmazione del verde per la città di Avellino sarà l’investimento arboreo e arbustivo delle “aree derivanti dalle previsioni del Piano Urbanistico Comunale” che ammontano ad oltre 37 ha (“Parco Territoriale del Fenestrelle”, “Zone di Trasformazione. Ambiti di attuazione perequativa” e “Aree a Standard D.I.1444/1968”). Per quanto attiene all’uso del suolo, il Piano del verde di Avellino prevede l’eliminazione o la prevenzione dei dissesti idrogeologici negli Habitat di appoggio, quali gli ambiti boschivi o il parco territoriale previsto dal PUC.
Inoltre, sul fronte dell’adattamento e della mitigazione ai cambiamenti climatici, diventa indispensabile favorire meccanismi di compensazione ambientale attraverso la realizzazione di nuove unità ecosistemiche efficaci per ridurre i gas serra e rendere il territorio urbano resiliente ai cambiamenti climatici. Il Piano si propone di contrastare l’effetto serra e contenere le emissioni CO2 attraverso la piantagione di alberi di prima grandezza che potrebbero in parte essere utilizzati per la forestazione delle fasce di rispetto stradale e in parte per la realizzazione di parchi urbani. La progettazione degli spazi urbani in chiave di adattamento climatico dovrà privilegiare materiali con adeguate caratteristiche tecniche, inserire acqua e alberi per la riduzione della temperatura, l’ombreggiamento e il comfort termico, adottando la gestione sostenibile delle acque pluviali urbane con soluzioni che coniughino la riduzione del runoff e la realizzazione di spazi verdi multifunzionali, la permeabilità dei suoli, il miglioramento del microclima e la riduzione degli inquinanti.
Gli indicatori di monitoraggio dei Piani comunali del verde di Avellino:
Il Piano contiene degli obiettivi a breve (gestione e manutenzione dell’esistente), medio (gestione del verde previsto dai piani urbanistici attuativi) e lungo periodo (per le aree del Piano intercomunale di interesse regionale del Fenestrelle. Gli indicatori di monitoraggio proposti sono:
- Presenza/assenza degli strumenti di governo del verde (Censimento, Regolamento e Piano)
- Bilancio del verde: percentuale di verde pubblico sul totale della superficie comunale (disaggregato per tipologie a diversi regimi di tutela e vincoli)
- Bilancio arboreo: numero di alberi a fine e inizio mandato del Sindaco del Comune (in attuazione della Legge 10/2013)
- Numero di aree assegnate/in adozione alle associazioni e/o ai cittadini
- Green budget: percentuale di budget allocato al settore del verde pubblico sul budget totale comunale (disaggregato per voci di spesa: pianificazione e gestione, monitoraggio della stabilità degli alberi, personale impiegato, ecc.)
- Alberi monumentali: numero di alberi monumentali censiti e/o tutelati ai sensi dell’articolo 7 della Legge 10/2013
- Acquisti verdi: recepimento dei Criteri Ambientali Minimi nel settore del verde pubblico
- Indice di copertura arborea: rapporto tra la copertura arborea (superficie di proiezione a terra stimata o rilevata delle chiome) e la superficie totale degli spazi verdi gestiti x 100
- Percentuale di rinnovo delle alberate: rapporto tra il numero di nuovi impianti arborei e il numero totale dei soggetti arborei in piedi x 100 (al 31/12 di ogni anno)
- Dotazione ludica: rapporto tra il numero di abitanti di età compresa tra 0-14 anni e il numero delle aree ludiche (al 31/12 di ogni anno)
- Lavoratori verdi: indice espresso con il rapporto percentuale del personale tecnico che si occupa dei giardini (giardinieri, tecnici e amministrativi utilizzati nelle strutture) e il numero del personale impiegato dall’amministrazione
- Indice di specializzazione del personale impiegato nel settore verde