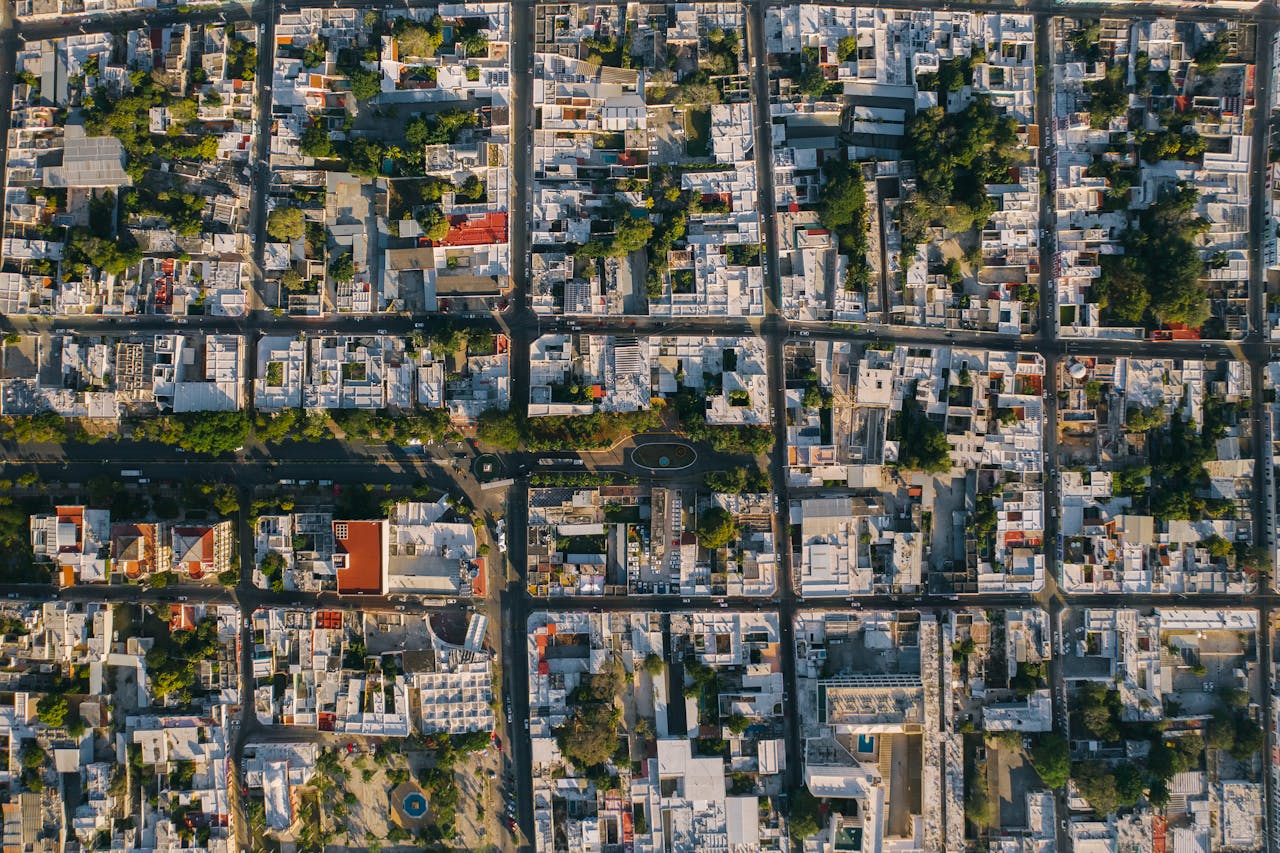Gli schemi di responsabilità estesa del produttore sono invocati in tutte Europa come modelli efficienti per la gestione dei rifiuti nell’ottica dell’economia circolare. Rispondono al principio del chi inquina paga e in Italia, oggi, riguardano una molteplicità di rifiuti. Ma sono davvero così efficienti?
I rifiuti più che avere un volto monolitico, ben definito e riconoscibile, assomigliano a un mosaico senza volto, le cui tessere, sfuggenti, vanno ricomposte volta per volta, giorno per giorno.
I rifiuti, infatti, non sono una realtà unica ma si articolano in numerose filiere, e anche la loro gestione non è a un’unica corsia e si rifà sia alla modalità pubblica, ovvero tramite regimi di privativa nel caso dei rifiuti urbani, che a modalità di mercato, in riferimento ai rifiuti speciali, ovvero quelli prodotti dalle attività economiche e che rappresentano circa l’’85% del totale prodotto ogni anno, è bene ricordare. Pubblico e privato concorrono, ciascuno nel proprio perimetro (urbani e speciali), a dare una governance al sistema.
In mezzo a questa classica dicotomia pubblico/privato si è insinuata sin dalla fine degli anni Novanta una figura ibrida, ovvero la responsabilità estesa del produttore, che, almeno in teoria, dovrebbe introiettare nella governance il principio del chi inquina paga, con finalità marcatamente ambientali. Una novità assoluta rispetto al passato, un’idea di origine nord europea che si pone l’arduo compito di trovare una sintesi tra la tutela dell’ambiente, ripartendone le responsabilità del post-vita dei prodotti tra i diversi attori, e i meccanismi di mercato. Un equilibrio in effetti difficile da raggiungere e che non sempre si riesce a raggiungere.
Il testo unico ambientale
All’inizio dell’intelaiatura normativa, infatti, il Dlgs 152/2006 meglio noto come Testo Unico Ambientale – TUA (art. 178), precisa in maniera solenne che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, (nel rispetto del principio di concorrenza) nonché del principio chi inquina paga”.
Senza perdere tempo, l’articolo successivo, il 178 bis, affida al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE (nelle sue continue metamorfosi lessicali) il compito di istituire (tramite apposito Decreto ministeriale), per singole tipologie di rifiuti, schemi operativi di responsabilità estesa del produttore (in inglese Extended Producer Responsability – da cui l’acronimo in uso anche da noi di EPR). L’obiettivo? Assicurare il raggiungimento delle finalità poste in premessa, ovvero “rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti”.
La gerarchia dei rifiuti
Più nel dettaglio, il Dlgs 116/2020, che recepisce la nuova Direttiva Ue 851/2018, chiede ai produttori di gestire il fine vita dei prodotti da loro stessi immessi sul mercato, “attraverso una responsabilità finanziaria o una responsabilità finanziaria e organizzativa, che può essere attuata in forma individuale o collettiva”.
Rispettando quindi in maniera scrupolosa la gerarchia dei rifiuti, che, ripetiamolo, predilige le politiche di prevenzione, i commi seguenti si affrettano a sottolineare che i regimi di responsabilità estesa del produttore prevedano “misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti[..]”.
Misure che debbono comunque “incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti”. E ancora, le misure devono in ogni caso tenere conto “dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo”.
Quindi, i principi di circolarità devono essere applicati a tutte le fasi di una catena del valore per garantire il successo dell’economia circolare. Dalla progettazione alla produzione, lungo tutta la filiera fino al consumatore.
Quali sono finora i rifiuti gestiti in Italia con questo meccanismo?
Imballaggi e i rifiuti di imballaggio (carta e cartone, vetro, plastiche, legno, acciaio e alluminio), rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), pneumatici fuori uso (Pfu), veicoli fuori uso, oli minerali, oli e grassi vegetali e, infine, rifiuti in polietilene.
Come si finanziano questi schemi?
Attraverso il cosiddetto ecocontributo, ovvero un extra costo che i produttori aggiungono al prezzo finale al momento della messa nel mercato. Sovrapprezzo che alla fine pagano i consumatori al momento dell’acquisto con lo stesso meccanismo dell’Iva, per capirci. Quindi a pagarlo sono i cittadini, in questo caso nella loro veste di consumatori. Costo che si somma alla tassa sui rifiuti (Tari) che pagano comunque tutti i cittadini per la gestione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Paghiamo due volte, insomma, come consumatori e come cittadini, naturalmente per dare gambe alla transizione ecologica.
Quali sono le forme di gestione?
Come accennato, per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, i produttori dei prodotti si possono organizzare sia individualmente, cioè provvedendo autonomamente alla raccolta, oppure in forme collettive, cioè attraverso delle società consortili costituite ad hoc, senza scopo di lucro, che hanno, o meglio dovrebbero, avere quale mission quella di garantire il rispetto dell’obbligo previsto dal sistema di EPR di riferimento.
Nella realtà, però, non sempre i principi preconizzati in astratto prendono vita, per ragioni diverse.
Una delle più immediate deriva dal fatto che se a pagare alla fine è sempre il consumatore e se i produttori incassano sulla base del venduto (che comprende anche il contributo ambientale) è chiaro che l’incentivo a ridurre la produzione (di beni che poi diventeranno rifiuti) diventa un nonsenso, almeno in una logica prettamente economica.
Non a caso negli schemi di EPR in vigore gli obiettivi di riduzione e riutilizzo sono rimasti sostanzialmente sullo sfondo, mentre solo il riciclo ha trovato il suo meritato spazio. Ed è esattamente questa la ragione principale che ha spinto l’UE, per esempio, ad attivarsi per riformare la cd Direttiva Imballaggi, questa volta tramite lo strumento normativo del Regolamento Ue (a differenza della Direttiva, direttamente applicabile negli stati membri), scatenando le ire del Governo in carica e di alcuni consorzi. Commissione che allo stesso tempo chiede ai paesi membri di attivare schemi di EPR anche in altre filiere, su tutti il tessile.
Per dirne un’altra, se, almeno in teoria, il contributo ambientale è stato immaginato per essere modulato sulla base delle effettive capacità di riciclo/riuso del bene a cui si applica – disincentivando la produzione di beni non riutilizzabili/riciclabili –, finora solo nel caso delle plastiche e in parte della carta e cartone ciò è realmente accaduto (e solo di recente), per il resto la determinazione del contributo ambientale rimane una scelte assunta dalle aziende all’interno dei propri bilanci, per rispondere a esigenze prevalentemente interne.
Insomma, se lo scopo principale dell’EPR dovrebbe essere quello di garantire una gestione dei rifiuti impostata sulla prevenzione e sulla migliore tutela ambientale possibile, spetterebbe, invece, alla politiche pubbliche e ai suoi numeri strumenti economici e fiscali il compito di sostenere concretamente la transizione ecologica, per esempio, costruendo mercati competitivi e nuovi sbocchi ai materiali da riciclo. Condizionale d’obbligo, naturalmente.
La responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti
Attribuire la responsabilità della gestione dei rifiuti direttamente ai produttori dei beni immessi nel mercato è diventata una delle tante parole d’ordine, persino abusata, dell’economia circolare. In tutta l’UE gli schemi di responsabilità estesa del produttore (EPR in inglese) vengono invocati per la gestione delle più disparate tipologie di rifiuti, come in Italia che vi ha già fatto ampio ricorso, anche se non mancano le contraddizioni