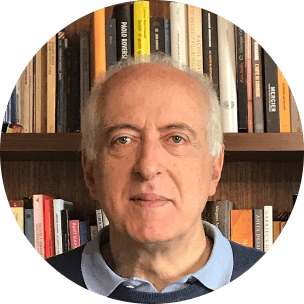Le grandi sfide che la comunità internazionale si trova oggi a fronteggiare, dal cambiamento climatico alle tensioni geo-politiche, richiederebbero forme di collaborazione tra gli Stati basate sul principio di condivisione di sovranità. Guerre in corso e svolta nazionalistica degli Stati Uniti non fanno ben sperare. Che prospettive ci sono per il multilateralismo?
Sono passati 30 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo di Marrakech, il 1° gennaio 1995, e dalla nascita dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), l’istituzione multilaterale preposta a favorire il processo di liberalizzazione degli scambi internazionali. Fu così perfezionato il sistema globale nato alla fine della II guerra mondiale, con la Conferenza di Bretton Woods, che aveva creato un insieme di regole e istituzioni per promuovere crescita economica e stabilità monetaria in tutti i Paesi.
Lo scenario mondiale appare oggi molto più cupo, insanguinato da guerre e atrocità alimentate in un circolo vizioso dall’ondata di nazionalismo che dilaga anche in paesi apparentemente lontani dai fronti di combattimento. Il processo di globalizzazione, che fino alla crisi finanziaria del 2008 aveva contribuito a diffondere impulsi espansivi e a ridurre i divari di sviluppo tra le economie, appare frenato.
Le politiche commerciali hanno assunto in molti Paesi un orientamento protezionista, che si traduce nel tentativo di scaricare i problemi interni sul resto del mondo, alimentando spirali pericolose di ritorsioni reciproche. Acquista consenso anche in Europa una visione deformata delle relazioni internazionali, in cui i governi competono tra loro come se fossero imprese, invece di cooperare per aprire i mercati alla concorrenza e creare condizioni favorevoli al dispiegarsi dei suoi benefici, curando al tempo stesso i problemi sociali che possono derivarne. Queste difficoltà politiche riflettono un cambiamento negli orientamenti dell’opinione pubblica, sempre più ostili alla globalizzazione e alle istituzioni internazionali e permeabili da varie forme di ossessioni identitarie nazionali e locali. Paradossalmente, questi mutamenti si accentuano in una fase storica in cui invece le grandi sfide che fronteggia la comunità internazionale – il cambiamento climatico, le questioni demografiche e migratorie, l’aumento delle disuguaglianze, le tensioni geo-politiche, la rivoluzione digitale – richiederebbero forme di collaborazione più efficaci, basate sul principio della condivisione di sovranità a un livello istituzionale adeguato alla scala dei problemi da affrontare.
L’assalto agli accordi internazionali sull’ambiente
Tra le ragioni che alimentano il sostegno al protezionismo ci sono anche i danni che le politiche di liberalizzazione degli scambi possono arrecare all’ambiente, non soltanto per l’aumento di emissioni climalteranti, inquinamento ed esaurimento delle risorse naturali chel’attuale modello di crescita economica comporta, ma anche per l’adozione di standard produttivi al ribasso in termini di tutela dell’ambiente da parte di alcuni Paesi che hanno cercato di aumentare i profitti delle proprie imprese e attrarre investimenti esteri a scapito di chi applica regole più rigorose. I Paesi in via di sviluppo reclamano il diritto di seguire percorsi di crescita simili a quelli adottati in passato da quelli più sviluppati, senza doversi scontrare con sanzioni commerciali introdotte per imporre il rispetto di regole di sostenibilità delle produzioni.
L’idea che la proprietà e il controllo delle risorse naturali sia prerogativa nazionale, ovvero che ogni Paese possa contare sulle risorse collocate nel proprio territorio, senza tener conto del resto del mondo, genera tensioni difficili da risolvere che minano l’attuazione degli accordi internazionali sull’ambiente.
Una visione alternativa suggerisce che le risorse naturali vadano considerate come un bene pubblico globale, la cui riproduzione sostenibile è una responsabilità fondamentale dell’intera comunità internazionale e richiede politiche di cooperazione reciproca, assistite da un meccanismo istituzionale che consenta di sanzionare efficacemente eventuali comportamenti opportunistici dei singoli governi[1].
Dobbiamo anche tenere presente che gli effetti del commercio internazionale sull’ambiente non sono necessariamente negativi. La liberalizzazione degli scambi internazionali di beni e servizi utili per l’ambiente potrebbe aumentarne l’accessibilità in Paesi che non abbiano ancora maturato vantaggi comparati nella loro produzione. Inoltre, lo sviluppo di filiere produttive internazionali in settori come le energie rinnovabili e l’economia circolare potrebbe facilitare la diffusione di conoscenze e capacità innovative necessarie per la rigenerazione dei territori e la salvaguardia del pianeta.
La politica commerciale UE: liberalizzazione e rispetto dell’ambiente
Non siamo dunque in presenza di un dilemma secco, in cui gli obiettivi ambientali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite possano essere perseguiti soltanto sacrificando i benefici della globalizzazione. Al contrario, esiste un margine di manovra per fare in modo che misure volte a promuovere l’apertura internazionale dei sistemi produttivi locali ne migliorino la sostenibilità ambientale.
È proprio questa la visione che ispira la politica commerciale dell’Unione Europea e in particolare i suoi accordi preferenziali con i principali partner esterni[2]. Mentre in passato questi accordi si limitavano a prevedere misure di liberalizzazione degli scambi e degli investimenti, nei negoziati più recenti sono state introdotte anche regole per tutelare i diritti del lavoro e l’ambiente. Ne è un esempio il recentissimo accordo di partenariato con il Mercosur (Mercado Común del Sur), l’area di integrazione regionale formata da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, che prevede un’ampia riduzione delle barriere agli scambi e agli investimenti, accompagnata da impegni precisi per la protezione dei diritti delle persone che lavorano, il rispetto dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico e la lotta alla deforestazione. L’accordo è il frutto di negoziati lunghi e contrastati e la sua ratifica è ancora incerta, ma il suo valore politico consiste proprio nel mostrare la possibilità di conciliare crescita economica e salvaguardia ambientale.
Negoziati simili sono stati condotti o sono in corso con altri partner dell’Unione Europea.
Tuttavia, accordi di questo tipo incontrano le resistenze protezionistiche di alcuni Paesi europei che temono la concorrenza di prodotti a prezzi più bassi. E, simmetricamente, la diffidenza di alcuni Paesi in via di sviluppo che temono norme di tutela dell’ambiente e del lavoro, percepite come ostacoli ingiustificati a una maggiore penetrazione dei propri prodotti nei mercati europei.
Che prospettive per il multilateralismo?
Nella fase attuale, segnata dalle guerre in corso e dalla brusca svolta nazionalistica degli Stati Uniti, le prospettive del sistema commerciale multilaterale appaiono oscure. Ma è proprio la gravità della situazione a sottolineare la grande opportunità che ha davanti a sé l’Unione Europea per provare a esercitare un ruolo di leadership globale, rafforzando la propria politica di cooperazione internazionale e costruendo alleanze basate sul principio di interdipendenza strategica – piuttosto che sull’ossessione per la sicurezza e l’autonomia – e sul consolidamento del sistema multilaterale. Si tratta non soltanto di intervenire per cercare il consenso necessario a superare lo stallo in cui si trova l’OMC, riformandone i meccanismi di funzionamento, ma anche di riconoscere il fatto che una sintesi adeguata tra liberalizzazione commerciale e tutela ambientale può essere trovata soltanto in un contesto più ampio, che includa altre organizzazioni internazionali e regionali.
È questa la prospettiva che ispira il Villars Framework for a Sustainable Trade System, una proposta di riforma dell’OMC basata sull’idea che lo sviluppo sostenibile, nei suoi aspetti ambientali, economici e sociali, debba essere indicato come l’obiettivo fondamentale del sistema commerciale multilaterale, rinnovando l’impegno assunto nel 1994 con l’Accordo di Marrakech.
La qualità di queste riforme andrà valutata in base alla loro capacità di coinvolgere i Paesi e i territori più poveri e vulnerabili al cambiamento climatico. Si tratta non soltanto di una condizione essenziale per ottenere il consenso politico necessario alla loro attuazione, ma soprattutto di una questione di giustizia sociale e ambientale, ovvero di contrasto all’aumento delle disuguaglianze tra le persone, i territori e le generazioni.
Il deterioramento delle relazioni politiche internazionali fa apparire oggi come velleitario qualsiasi progetto volto a rafforzare le istituzioni multilaterali. Eppure – e proprio per questo – occorre impegnarsi per costruire con pazienza le condizioni culturali, sociali e politiche per invertire le tendenze in corso e restituire un futuro di speranza al genere umano e al pianeta che lo ospita.
[1] Sul concetto di “beni pubblici globali” cfr. I. Kaule, I. Grunberg e M.A. Stern (a cura di), Global Public Goods. International Cooperation in the 21st Century, United Nations Development Programme, Oxford University Press, 1999.
[2] Cfr. C. Castelli, “I negoziati commerciali dell’Unione Europea”, in Italian Trade Agency (ITA), L’Italia nell’economia internazionale. Rapporto ICE 2023-2024, pp. 37-42, https://www.ice.it/it/rapporto-ice-annuario-istat-ice-2024