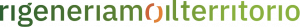Adeguarsi alla transizione energetica, aumentando al tempo stesso produttività e competitività. È questa la sfida che le PMI italiane hanno di fronte, che richiede la costruzione o il rafforzamento di ecosistemi territoriali di innovazione.
Nel contesto della grande trasformazione della vita economica e sociale generata dalle tecnologie digitali, gli economisti si interrogano da molto tempo sulle ragioni per cui la crescita della produttività, che dovrebbe risentire positivamente delle innovazioni digitali, appaia invece in sensibile rallentamento in tutti i principali Paesi (il “paradosso della produttività”). Mettendo da parte i possibili errori di misurazione statistica dei processi analizzati, che tuttavia potrebbero essersi ampliati per la difficoltà di catturare nei dati fenomeni nuovi e molto dinamici, una corrente di pensiero, che fa riferimento agli studi di Robert Gordon[1], sostiene che la trasformazione digitale dell’economia avrebbe in realtà un impatto minore di quello attribuito alle grandi rivoluzioni industriali del passato e dunque il fatto che la crescita della produttività non mostri segni di accelerazione non avrebbe nulla di paradossale.
Di parere opposto sono coloro che ritengono, come Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee[2], che le tecnologie digitali, soprattutto quelle legate all’intelligenza artificiale e alla robotica, abbiano effettivamente un carattere rivoluzionario rispetto ai paradigmi produttivi del passato, ma che i dati sulla produttività non ne mostrino ancora i segni, a causa del ritardo con cui le innovazioni che ne derivano si diffondono nei sistemi imprenditoriali. Tali ritardi potrebbero essere stati ampliati dalla crescente concentrazione delle conoscenze nei grandi oligopoli digitali e dalle barriere che la proteggono, legate ai sistemi di tutela della proprietà intellettuale.
Le fragilità del sistema imprenditoriale italiano
In questo contesto dinamico e incerto, oscurato dal tragico deterioramento dello scenario geo-politico, l’economia italiana appare particolarmente vulnerabile, penalizzata dai cronici problemi strutturali che ne hanno frenato la crescita nell’ultimo trentennio, mantenendola tendenzialmente inferiore a quella degli altri principali Paesi sviluppati. Malgrado alcuni segni incoraggianti emersi recentemente nell’industria manifatturiera, come effetto dei processi di ristrutturazione e selezione competitiva delle imprese più esposte alla concorrenza internazionale, la produttività del lavoro nel totale dell’economia è rimasta stagnante, inferiore alla pur modesta media dell’Eurozona.
La crescita dell’economia italiana, almeno a partire dagli anni ‘90, è stata strutturalmente frenata dalla scarsa produttività e capacità innovativa delle imprese di minori dimensioni. Per varie ragioni – tra cui i limiti manageriali della gestione familiare e il ruolo preponderante del finanziamento bancario tradizionale – molte piccole e medie imprese (PMI) italiane non hanno saputo realizzare investimenti adeguati in attività innovative. Il problema è stato acuito dalla rivoluzione digitale, che ha accentuato la concentrazione oligopolistica delle conoscenze, aggravando la crisi di molte imprese minori, soprattutto nei settori tradizionali.
Se, fino agli anni ’70 – ’80, le PMI italiane avevano potuto assorbire le innovazioni che venivano dai centri di ricerca e dalle imprese maggiori di ogni Paese, perché tali innovazioni erano incorporate nelle macchine, la rivoluzione digitale ha preso in contropiede questo sistema. La conoscenza scientifica necessaria per innovare è ora prevalentemente scorporata dal capitale materiale e la sua concentrazione in poche grandi imprese ha fatto sì che molte innovazioni siano diventate, di fatto, inaccessibili alla maggior parte delle PMI, se non a costi proibitivi. Più in generale, il processo di concentrazione della proprietà intellettuale, che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ha contribuito a ridurre le opportunità di investimento per le imprese, impedendo di recuperare la perdita di capacità produttiva generata dalla crisi globale.
Si è così prodotta una polarizzazione tra due tipi di PMI:
- alcune (poche) che innovano, fanno scambi internazionali e garantiscono buone condizioni di lavoro;
- molte imprese statiche, che riescono a sopravvivere solo grazie a bassi salari, cattivi lavori, ampi margini di elusione ed evasione fiscale e sussidi pubblici.
Le PMI di fronte alla sfida del cambiamento climatico
Questo sistema imprenditoriale, con le sue luci e le sue ombre, è ora esposto a un’altra sfida estremamente impegnativa: come adattare i suoi paradigmi produttivi ai vincoli posti dal cambiamento climatico e dalle politiche necessarie per mitigarne le conseguenze. Benché la questione si presenti in termini diversi a seconda dei settori in cui operano le imprese, più o meno caratterizzati da un uso intensivo delle fonti energetiche fossili, essa investe tutto il sistema produttivo, non soltanto per le interdipendenze esistenti nelle reti di fornitura tra i settori, ma anche per i mutamenti in corso nei modelli di consumo, con una maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale delle scelte di acquisto.
Nel dibattito pubblico circola un’interpretazione ansiogena di questi problemi, tesa a sottolinearne i costi per le imprese, prefigurando possibili conseguenze negative per l’occupazione e i salari. Ne sono espressione sia le posizioni di chi afferma che il cambiamento climatico non esiste, o comunque non è di origine antropica, sia quelle di chi chiede di rinviare il più a lungo possibile le trasformazioni che esso impone nei modelli produttivi. Una miopia che, indipendentemente dalle intenzioni di chi ne è affetto, finisce per favorire i gruppi di potere legati alle rendite dei combustibili fossili.
È viceversa possibile documentare, sulla base di molte esperienze concrete realizzate da comunità che hanno scelto di affrontare seriamente la questione climatica, come essa offra grandi opportunità di rigenerazione dei modelli produttivi e dei luoghi in cui vengono svolti, con conseguenze positive per il mondo del lavoro[3]. Le PMI rappresentano naturalmente, in tutti i Paesi, una quota molto ampia dei sistemi produttivi e quindi incidono in misura notevole sia sui consumi energetici, sia sulle emissioni di gas climalteranti. L’aumento dei prezzi delle materie prime, innescato dall’invasione russa dell’Ucraina, ha innalzato considerevolmente la loro incidenza sui costi delle imprese.
È di fronte a questi problemi che emerge il contributo positivo, ancora poco riconosciuto, che le tecnologie digitali possono arrecare alla trasformazione dei modelli produttivi delle PMI. Sistemi digitali di misurazione e controllo dei consumi, come ad esempio i sensori connessi posti negli edifici, possono accrescere l’efficienza energetica delle imprese, facilitando l’adozione di comportamenti virtuosi. Inoltre, le tecnologie digitali possono facilitare l’introduzione di pratiche di micro-generazione di energia rinnovabile e più in generale il cambiamento dei modelli produttivi delle PMI secondo i principi dell’economia circolare.
Tuttavia, ostacoli importanti derivano, come in altri ambiti di innovazione, dalle difficoltà di accesso al credito delle PMI e dalla loro insufficiente consapevolezza delle opportunità offerte dal digitale e dei vincoli posti dalle regole sulla transizione climatica, a sua volta dovuta ai limiti delle pratiche manageriali e delle competenze di cui dispongono. Un più ampio accesso delle PMI a fonti di finanziamento legate a parametri di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario (ESG) appare ormai essenziale per consentirne la crescita e le innovazioni digitali possono svolgere un ruolo importante per facilitare il loro adattamento ai requisiti della finanza sostenibile.
Per le PMI servono nuovi ecosistemi territoriali dell’innovazione
Il mondo delle PMI è molto diversificato. Se è vero che la maggior parte di esse deve affrontare problemi rilevanti di accesso alle innovazioni, va riconosciuto anche che esistono molte piccole imprese che già operano alla frontiera delle tecnologie digitali e anzi sono un terreno naturale di sperimentazione di nuove soluzioni produttive.
La questione decisiva, dunque, riguarda i sistemi nazionali e locali di diffusione delle innovazioni. La loro importanza è stata riconosciuta anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha assegnato oltre 9 miliardi di euro alla componente 2 (“Dalla ricerca all’impresa”) della sua missione 4 (“Istruzione e ricerca”). Questi fondi vengono usati per avviare le attività di varie forme di partenariato tra università, enti di ricerca e imprese (Partenariati estesi, “campioni nazionali di R&S”, Ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità), che si aggiungono a quelle già esistenti, ad esempio nell’ambito del Piano Industria 4.0, come i Centri di competenza e i Poli di innovazione digitale. Il rischio è quello di creare una pletora di strutture diverse di intermediazione delle conoscenze, che fanno capo a ministeri diversi, senza adeguati strumenti di valutazione del loro impatto. Ma un rischio ancora più insidioso è quello di limitarsi a finanziare le infrastrutture di ricerca e il reclutamento del personale (con l’aggravante che il PNRR non consente di finanziare spese correnti per personale a tempo indeterminato), senza curarsi dell’effettivo funzionamento dei processi di diffusione delle conoscenze tra le imprese.
La questione viene ancora interpretata secondo la visione tradizionale del trasferimento tecnologico dai centri di ricerca alle imprese, senza considerare il fatto che le conoscenze rilevanti, soprattutto per la trasformazione digitale dell’economia, non sono soltanto quelle tecnologiche, ma anche quelle organizzative e, più in generale, i fattori culturali che si riflettono nelle capacità del personale. I processi di diffusione delle conoscenze sono oggi caratterizzati dal multilateralismo: non sono soltanto i centri di ricerca a trasferire conoscenze verso il resto della società, ma tutti i soggetti che partecipano agli eco-sistemi dell’innovazione, che realizzano processi di apprendimento reciproco, stimolando anche le attività di ricerca.
La visione tradizionale del trasferimento tecnologico dai centri di ricerca alle imprese rischia anche di alimentare incentivi distorti, spingendo le università a cercare opportunità di valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, senza curarsi della loro ricaduta sociale. Questo problema si intreccia con i vincoli posti dalle regole di tutela della proprietà intellettuale: ad esempio, l’enfasi posta sulla registrazione dei brevetti sulle invenzioni prodotte nei laboratori di ricerca potrebbe concorrere a innalzare barriere alla diffusione delle innovazioni tra le PMI, ponendosi in contrasto con la visione dell’open science.
Nelle politiche per l’innovazione digitale la sfida più difficile, che rischia di essere oscurata dalla fretta di spendere i fondi del PNRR, è quella di come costruire o rafforzare eco-sistemi territoriali dell’innovazione che siano effettivamente in grado di comprendere e soddisfare il fabbisogno di innovazione delle PMI, usando le leve della trasformazione digitale dei processi produttivi per adeguarli alle esigenze della transizione climatica, aumentando al tempo stesso la produttività e la competitività delle imprese.
[1] R. Gordon, The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War, Princeton University Press, 2016.
[2] E. Brynjolfsson e A. McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, Norton, 2014.
[3] Cfr. C. F. Sabel e D. G. Victor, Fixing the Climate, Princeton University Press, 2022.